Dovendo scegliere una facoltà, però, non avrei mai voluto prendere Lettere (pensavo: "Non c'è nulla lì che non possa imparare per conto mio"), e pensai che con Psicologia avrei potuto ricavare il necessario per scrivere storie credibili con personaggi verosimili. A 17 anni avevo accantonato il problema e trovai nella libreria di famiglia un libro, "Psicologia come scienza del comportamento", che mi indirizzò alla disciplina, al di fuori della scrittura, che praticamente abbandonai.
Ora come ora posso dire di poter tirare le somme e valutare su per giù le strategie usate nella fiction per delineare la personalità e il comportamento dei personaggi all'interno di una storia. Questi sono solo alcuni miti/cliché, in futuro potrei trattarne altri.
Il signore del male (The Evil Overlord)
Che sia un fantasy, un thriller, un horror, le caratteristiche del cattivo di turno sono sempre quelle.
La tendenza principale (da parte degli autori, sia di narrativa che di serie tv o cinema) è quella di renderlo un genio del male o un malvagio imprevedibile senza pietà. In ogni caso, le caratteristiche dell'Evil Overlord della fiction riflettono i criteri diagnostici del DSM-IV¹ relativi al Disturbo Antisociale di Personalità:
A) il soggetto mostra inosservanza e violazione dei diritti degli altri fin dall'età di 15 anni, che si manifesta con almeno 3 dei seguenti elementi:Delle due figure, nel mondo reale è più probabile incontrare il secondo tipo, quello del malvagio oltrenatura, il cattivo che ora sta scherzando col suo scagnozzo e subito dopo gli spara in testa, il cattivo che uccide bambini di fronte alla loro famiglia e famiglie davanti ai loro bambini, che beve il sangue delle sue vittime usando come coppa il cranio della madre assassinata con le proprie mani, su un trono di ossa ecc.
1. incapacità di conformarsi alle norme sociali per quanto riguarda il comportamento legale, con ripetersi di condotte suscettibili di arresto
2. disonestà: il soggetto mente, usa falsi nomi, truffa gli altri
3. impulsività o incapacità di pianificare
4. irritabilità e aggressività
5. inosservanza della sicurezza propria e degli altri
6. irresponsabilità: incapacità di far fronte a obblighi finanziari o di sostenere un'attività lavorativa con continuità
7. mancanza di rimorso
B) l'individuo ha almeno 18 anni
C) presenza di un disturbo della condotta con esordio precedente ai 15 anni
D) il comportamento antisociale non si manifesta esclusivamente durante un episodio maniacale o nel decorso della schizofrenia
Questo tipo di cattivo non esiste: le uniche persone in grado di fare questo genere di cose sono psicotici, persone che hanno un contatto con la realtà assente o gravemente alterato (per esempio, alcuni schizofrenici).
Ora, questo non significa che gli psicotici siano tutti assassini (anche se alcuni lo sono), tuttavia i comportamenti più bizzarri e palesemente inverosimili appartengono spesso a questo tipo di persone, per esempio sotto forma di deliri e allucinazioni.
Non sarebbe corretto dire che una persona psicotica non è in grado di elaborare un Piano Malvagio (come nella fiction) per distruggere il pianeta (a che pro, oltretutto?). Sarebbe corretto dire che potrebbe farlo, ma la motivazione sottostante sarebbe totalmente bizzarra, o ridicola, o assurda (del tipo: "Quando la signora Rossi mi ha chiesto quanto zucchero volessi nel caffè, in realtà mi stava leggendo la mente grazie ai microcongegni nel cervello che i marziani le hanno impiantato durante la notte, e che hanno impiantato a tutti gli altri del mio quartiere, e a quel punto mi è stato chiaro: devo distruggere la Terra, solo così potrò ottenere la salvezza del Coniglio"; chiaro, no?)
La figura del Genio del Male invece è meno credibile.
Sebbene nella teoria si parla di un continuum ai cui estremi ci sono il Narcisismo e il Disturbo Antisociale, con al centro il Narcisismo Maligno, è difficile che una persona totalmente antisociale sia in grado di conquistare la fiducia di molte persone, raggiungere posizioni di potere e ordire complicati piani di vendetta o di distruzione. Difficile, non impossibile. Tipicamente a riuscirci sono i politici, ma non sono individui antisociali, ma con possibili tratti antisociali, spesso tracci narcisistici. La personalità è complessa.
La maggior parte degli individui antisociali è costituita da poveracci (nel vero senso della parola), analfabeti, con un QI molto basso, cresciuti in condizioni di degrado, del tipo baraccopoli, a contatto costante con alcol, droga, violenza e abusi. Se non muoiono assassinati o per overdose, passano la vita in galera. Non hanno il tempo di organizzare complicati piani di vendetta che prevedano manipolazioni psicologiche e dissimulazioni varie. Se poi, come le ricerche stanno dimostrando, questi individui hanno alterazioni a livello della corteccia prefrontale, si comportano in maniera imprevedibile, ma secondo lo schema "faccio quello che mi va perché non ho alcun tipo di inibizione", quindi se anche deste una pistola in mano a un individuo simile e gli diceste "Guarda, quel tipo là ha dato della puttana a tua sorella", quello potrebbe sì andare dal tipo e ucciderlo, ma potrebbe anche avere voglia di farsi un giro in moto e ignorarvi, o andare a mangiarsi un panino, e via discorrendo. È disinibito, è imprevedibile.
Quindi possiamo stare tranquilli. Gli Evil Overlord di romanzi e film sono virtualmente impossibili. Ma ci sono sempre i politici.
Il trauma infantile
Il luogo comune, sia nella vita reale che nella fiction è questo: quando sei piccolo sei anche molto delicato psicologicamente, per cui una minima destabilizzazione può sconvolgerti al punto da determinare ciò che diventerai in futuro, con effetti perlopiù negativi. Tipicamente si tratta di un evento traumatico, e ancora più nello specifico, assistere a un evento drammatico.
Questo non è completamente vero, ma a grandi linee sì: nell'infanzia è tutto in via di sviluppo, e diversi fattori, compresi gli eventi stressanti, possono far cambiare la "direzione" di alcune linee di sviluppo, sia in positivo che in negativo.
Il trauma infantile però non determina sempre e comunque lo sviluppo di una psicopatologia in età adulta.
Assistere a una catastrofe, a un incidente, o alla morte di una persona, non fa necessariamente sbarellare l'individuo. Di conseguenza, quando in un romanzo o in un film si cerca di giustificare il comportamento (tipicamente teatrale) di un personaggio con la presenza di un trauma infantile nel suo background, in realtà si sta effettuando una certa forzatura, o comunque si sta ricorrendo a una facile scappatoia. Un individuo che sperimenta un trauma durante l'infanzia vive anche in un contesto che presenta diversi fattori, i cosiddetti fattori di rischio e i fattori di protezione.
Una buona condizione economica, un quoziente intellettivo alto, la presenza di una o più figure di riferimento, la vicinanza emotiva ecc., sono tutti fattori che modulano l'effetto del trauma e proteggono la persona. Viceversa, assenza di caregiver, lontananza affettiva, condizione economica scarsa, quoziente intellettivo basso, esposizione continua a stressor ecc., può peggiorare la situazione.
Di solito non è un evento traumatico a compromettere l'equilibrio psichico di una persona, ma la cronicità degli eventi traumatici, la continua esposizione a condizioni critiche, il cosiddetto trauma cumulativo (e.g., Follette et al., 1996).
Ci sono purtroppo tantissime persone che vivono in contesti familiari disfunzionali, continuamente esposte ad abusi fisici (violenza, incesto, ecc.) e psicologici (per esempio la svalutazione, "Tu non vali niente", "Sei inutile", ecc.), anche a rischio per la propria vita, e tutto questo per anni.
Ora, ciò non significa che chi ha "più esperienza traumatica" starà davvero male mentre chi ha vissuto solo un evento traumatico starà benissimo, come non averlo avuto affatto (anche se in realtà il numero di eventi traumatici è correlato alla gravità dei sintomi): per alcuni individui, con una certa struttura, anche un solo evento traumatico potrà essere significativo e potrà causare l'insorgenza di una psicopatologia. Tuttavia, la ricerca afferma che è meno probabile.
Di conseguenza, se volete scrivere una storia con un personaggio disturbato o serial killer o altro in conseguenza di un trauma infantile, assicuratevi che il contesto psico-sociale e la natura e la frequenza degli eventi traumatici vissuti durante l'infanzia sia appropriata. Altrimenti fate come vi pare: ci sono un sacco di personaggi poco credibili in romanzi e serie tv, ma nessuno ci fa molto caso.
A quanto pare il trauma è molto pittoresco.
Personalità, pensieri, atteggiamenti e comportamenti
Ogni individuo ha una sua personalità, composta da determinati tratti. I tratti di personalità costituiscono delle modalità relativamente stabili con cui un individuo pensa e si rapporta nei confronti del mondo, delle persone e di se stesso. Questo significa che, sempre considerando la Psicologia come scienza umana non deterministica ma probabilistica, la personalità implica pattern di pensiero e comportamento, grosso modo stabili e prevedibili.
In diverse fiction capita di leggere/vedere scene in cui la situazione è critica (per esempio, il leader e i forti del gruppo sono legati/immobilizzati e inermi e il Cattivo sta per ucciderli, dopo aver, sigh, spiegato il proprio piano malvagio) e un personaggio (per esempio, una bambina/un anziano pavida/o e debole che per tutta la storia è stata/o solo un peso nella quest) agisce in maniera assolutamente imprevedibile e controattitudinale (per esempio, sottrae la pistola a un tirapiedi, spara e becca il Cattivo alle spalle).
In situazioni estreme le persone possono comportarsi in maniera imprevedibile, diversa rispetto a come farebbero nella vita quotidiana? Può darsi, ma di solito no.
L'essere umano "si programma da solo" durante la vita. Ciò avviene principalmente attraverso la combinazione tra il proprio temperamento innato e atteggiamenti/comportamenti appresi. Un individuo tendenzialmente collerico, per dire, cresciuto in una famiglia avvezza alla violenza, intollerante verso le minoranze etniche, con personalità autoritaria (Adorno, 1950), schierata verso l'estrema destra, difficilmente penserà che non ci sono persone superiori e persone inferiori, che tutte le persone nel mondo sono uguali, che non esistono razze, che è importante aiutare i più deboli ecc. Quindi avrà specifici atteggiamenti razzisti e tutto ciò che ne consegue. La sua personalità è quella, gli atteggiamenti maturati nel tempo sono quelli, il comportamento che metterà in atto sarà coerente con tutto ciò.
Questa persona potrà cambiare? Sì. Ma non lo farà dall'oggi al domani (o alla fine rimarrà sempre uguale). Vedasi American history X.
L'esempio è un po' scomodo. Il cambio di bandiera politica è frequentissimo, quindi più che sull'ideologia politica vorrei soffermarmi sul bagaglio di atteggiamenti e convinzioni di un individuo, del tipo, "nella vita nessuno dà niente per niente", "Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio", "chi fa da sé fa per tre", o "chi fa del bene riceve del bene", o "le donne so' tutte zoccole", "gli uomini pensano solo a quello" ecc.: tutte convinzioni vere e false allo stesso tempo, ma che guidano il comportamento di un individuo.
Quindi: una persona si comporta in maniera coerente rispetto ai pattern di pensiero che strutturano la sua mente. Nel momento in cui agisce in maniera opposta al suo pensiero, subentra la Dissonanza cognitiva (Festinger, 1957): un eccessivo stress e disagio mentale che si avverte nel momento in cui c'è un conflitto tra atteggiamenti o tra atteggiamento e comportamento. L'esempio classico è quello della volpe e l'uva di Fedro, la volpe vuole l'uva, non riesce ad arrivarci, dice che è acerba.
Dato che un conflitto tra cognizioni e comportamento provoca un tale disagio mentale, un fastidio, è naturale che la gente si comporti in maniera coerente. Oltretutto è dimostrato (Lorenz 1963) che l'abitudine, i comportamenti appresi, portano l'individuo (nel caso di Lorenz si trattava di un'oca selvatica) a provare una fortissima paura nel momento in cui tale comportamento abitudinario non possa essere messo in atto nel modo usuale.
Potrebbe, dunque, il personaggio più scarso di una storia d'avventura/azione comportarsi in maniera totalmente diversa rispetto al solito? Dipende dalla sua personalità, atteggiamenti, bias di pensiero ecc.: quindi: in teoria sì, in pratica è improbabile.
Se mettete dunque un personaggio simile nella vostra storia e se per caso i personaggi più forti dovessero essere inermi e in pericolo di vita, temo che questi ultimi faranno una brutta fine.
____
Note
¹ DSM - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Per i profani, è il manuale delle malattie mentali. Wikipedia e l'Internet in generale possono darvi tutte le informazioni necessarie, ma in breve: le malattie (organiche e mentali) vengono catalogate in categorie strutturate (la cosiddetta nosografia), perché quando dài un nome a una cosa e la inquadri, è più facile concentrarvisi per porvi rimedio. Dare un'etichetta alle malattie è un affare macchinoso che la persona comune può criticare, ma essenzialmente è una cosa indispensabile sia dal punto di vista finanziario (per esempio, per usufruire di cure gratuite dal Sistema Sanitario Nazionale o dalle assicurazioni ecc.), sia dal punto di vista scientifico, sia dal punto di vista diagnostico e terapeutico: ci sono malattie che si assomigliano (anche mentali), e categorizzandole è possibile capire come procedere con ulteriori studi o in direzione della cura più adeguata.
____
Bibliografia minima
- Adorno, T. W., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D.J., Sanford, R. N. (1950). The Authoritarian Personality. Norton: NY.
- Festinger, L. (1957). A Theory of Cognitive Dissonance. California: Stanford University Press.
- Follette, V. M., Polusny, M. A., Bechtle, A. E., & Naugle, A. E. (1996). Cumulative trauma: The impact of child sexual abuse, adult sexual assault, and spouse abuse. Journal of traumatic stress, 9(1), 25-35.
- Lorenz, K. (1964). Das sogenannte Böse. Borotha-Schoeler., p. 112


 Lungi da me l'intenzione di scrivere un trattato: da poco prima che acquistassi un eReader fino a questo momento, ho letto, ascoltato e discusso riguardo alla questione del
Lungi da me l'intenzione di scrivere un trattato: da poco prima che acquistassi un eReader fino a questo momento, ho letto, ascoltato e discusso riguardo alla questione del 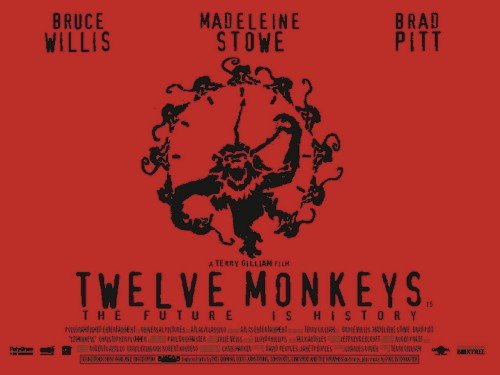 Un cult.
Un cult.
 Esco un attimo dal mondo della finzione per dedicare qualche parola all'attualità.
Esco un attimo dal mondo della finzione per dedicare qualche parola all'attualità.
